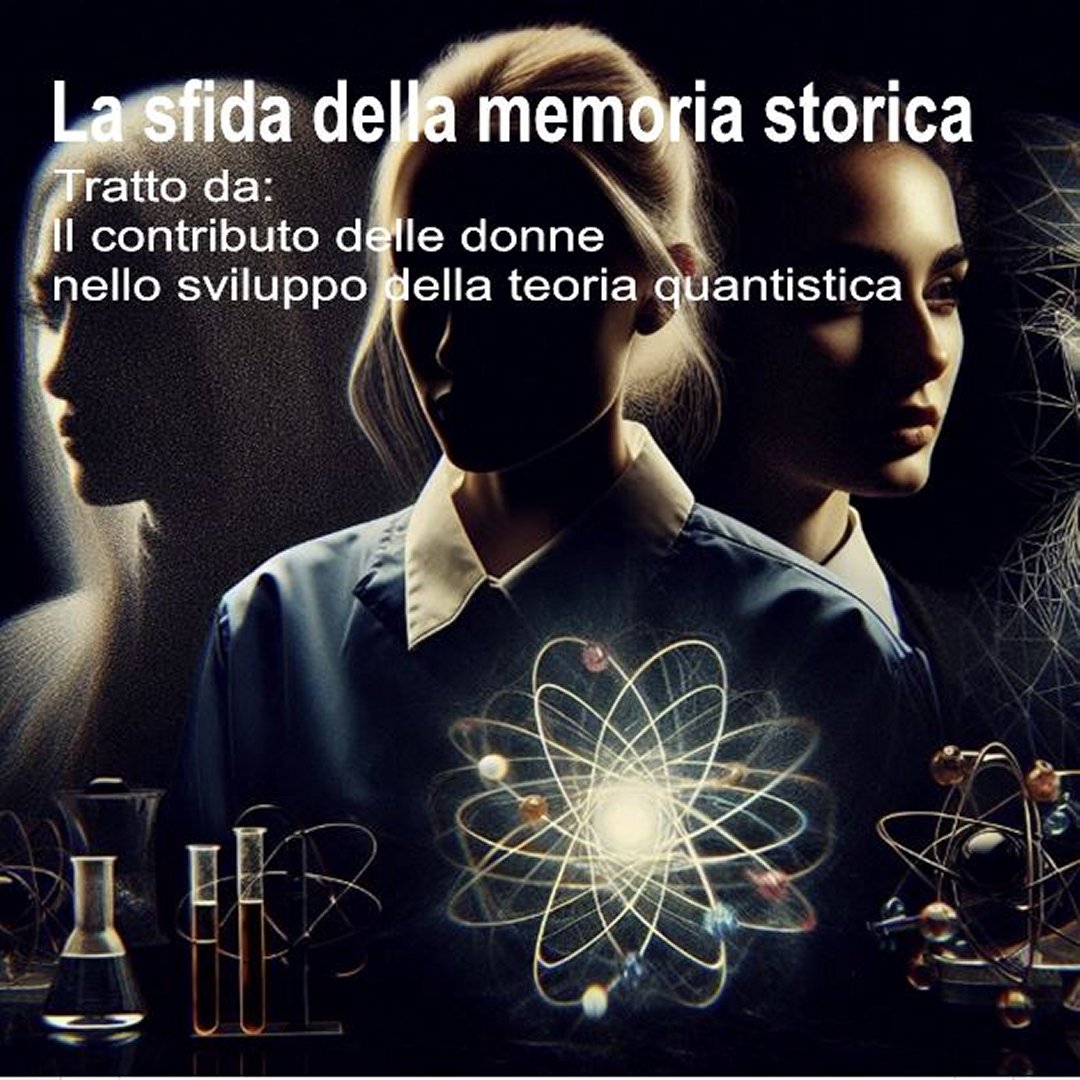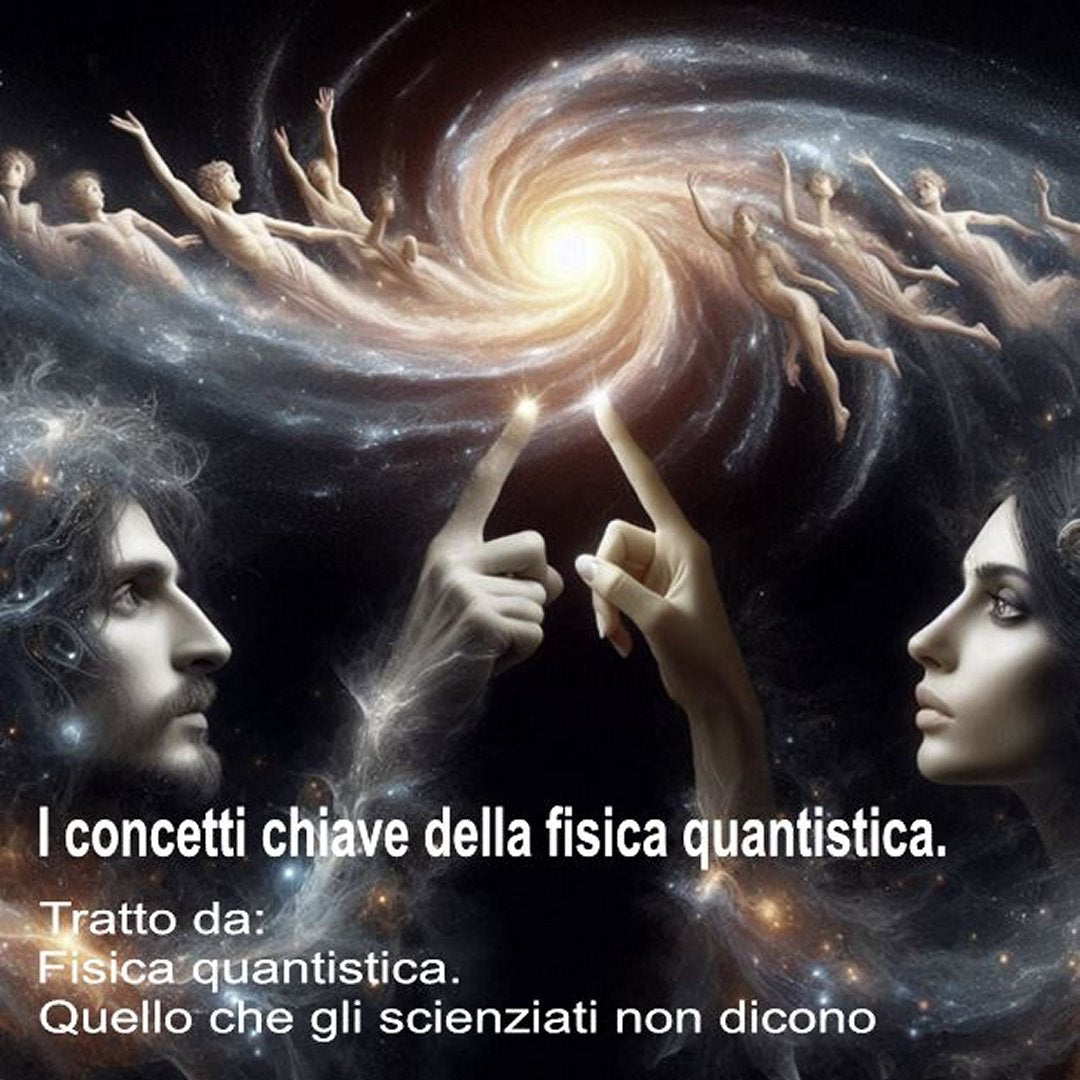La sfida della memoria storica.
La storia non è mai stata neutrale. È fatta da chi la scrive, ed è raccontata, troppo spesso, attraverso la voce dei vincitori, dei potenti, o più semplicemente degli uomini. Questo vale anche - e forse soprattutto - nel campo della scienza, un terreno che per secoli ha escluso le donne, o le ha relegato a margini imposti. La memoria storica si è rivelata particolarmente selettiva nei confronti del contributo delle scienziate, lasciando nella penombra nomi che avrebbero meritato un posto nella luce. Ridare visibilità a queste figure non significa solo fare giustizia, ma anche comprendere meglio il progresso scientifico, che è sempre stato il frutto di un coro, non di un monologo.
In fisica quantistica, questa selettività è evidente e dolorosa. La narrazione tradizionale attribuisce i progressi principali a un ristretto numero di uomini: Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, e alcuni altri. Ma queste stesse pagine di storia dimenticano le donne che, seppur combattendo contro ostacoli sociali e culturali enormi, hanno fornito contributi cruciali allo sviluppo della fisica moderna. Il loro destino è stato spesso lo stesso: invisibilità durante la vita, oblio dopo la morte.
Uno degli esempi più emblematici è quello di Lise Meitner. Nata nel 1878 a Vienna, Meitner apparteneva a una generazione di donne che dovevano lottare persino per accedere all'istruzione superiore. Era una delle pochissime donne a partecipare ai corsi universitari di fisica, un ambiente dominato da uomini dove spesso era trattata come un'intrusa. Nonostante ciò, il suo lavoro sulla fisica nucleare è stato fondamentale. Fu lei, insieme a Otto Hahn, a scoprire la fissione nucleare – una rivoluzione che ha sancito l’alba di una nuova era scientifica. Eppure, mentre Otto Hahn ricevette il premio Nobel per questa scoperta nel 1944, Meitner rimase nell’ombra. Lei stessa reagì con amarezza, con una frase passata alla storia:
“La scienza ha vinto, ma io ho perso”.
Questa esclusione non fu casuale. Il contesto patriarcale dell’epoca relegava le donne a ruoli subordinati, oppressi da pregiudizi che minavano non solo le loro carriere, ma anche la loro stessa esistenza professionale. Eppure, molte scienziate non si lasciarono abbattere. Ricordiamo Cecilia Payne-Gaposchkin, che nel 1925 dimostrò che l’idrogeno è il principale costituente delle stelle. I suoi colleghi uomini inizialmente ignorarono o rigettarono il suo lavoro. Solo anni dopo, lo stesso Henry Norris Russell, tra i più celebri astronomi dell’epoca, riconobbe che le sue intuizioni erano corrette. Anche in questo caso, la cultura dominante ritardò il riconoscimento di un contributo essenziale.
La questione dell’anonimato imposto riguarda anche il linguaggio e i ruoli assegnati all’interno della ricerca. Spesso le donne non potevano firmare i lavori con il proprio nome, o venivano relegate ad assistenti, nonostante il loro contributo effettivo fosse pari (se non superiore) a quello degli uomini che ufficialmente guidavano il progetto. Un caso interessante è quello di Mileva Marić, la prima moglie di Albert Einstein. Mileva Marić, anch’ella fisica e matematica, collaborava attivamente con Einstein, soprattutto nei primi anni della sua carriera. Diversi storici hanno ipotizzato che il suo lavoro abbia influenzato alcune delle idee fondamentali della teoria della relatività. Tuttavia, il suo nome non appare accanto a quello del marito.
Queste omissioni, tuttavia, non sono solo il riflesso di una società ingiusta. Incidono profondamente anche sulla percezione che le nuove generazioni hanno della scienza e dei suoi protagonisti. Le donne che vogliono intraprendere carriere scientifiche raramente trovano modelli femminili nell’insegnamento o nei libri di testo. La narrazione storica continua a confermare un pregiudizio che vede la scienza come “roba da uomini”, un pregiudizio che, paradossalmente, molte delle stesse donne dimenticate avevano contribuito a costruire.
Il recupero della memoria non è un atto di nostalgia, ma di responsabilità. È cruciale restituire alle scienziate il posto che meritano, anche andando oltre i pregiudizi e i miti costruiti sul loro conto. La storia della fisica quantistica, come quella di tante altre scienze, è fatta di una ricchezza che va oltre i nomi più celebri. Non recuperare questa memoria significa perdere opportunità preziose per comprendere come il progresso sia davvero avvenuto.
In questo spirito, sono sempre più numerose le iniziative volte a restituire visibilità alle donne dimenticate dalla storia della scienza. Oggi, a trent’anni dall’istituzione della “Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza” (celebrata l’11 febbraio), possiamo finalmente permetterci di guardare indietro con maggiore lucidità e magari colmare le lacune di una narrazione troppo parziale.
Raccontare le storie di queste pioniere non è solo un omaggio al passato. È un atto di giustizia verso il futuro. Restituire loro identità significa offrire alle nuove generazioni un ventaglio più ampio di possibilità, nel quale il genio scientifico non ha genere ma solo merito. Come ha scritto Marguerite Yourcenar,:
“Il nostro dovere verso la storia è di riscriverla”.
E, nel caso delle donne della scienza, questo dovere è ancora tutto da compiere.
Aneddoti sull’invisibilità delle donne nella scienza.
Raccontare la storia della scienza è un’impresa affascinante, ma può diventare anche un esercizio imbarazzante. Pagine e pagine sono state scritte per celebrare i giganti del pensiero scientifico. Eppure, quando si tratta di donne, il racconto della scienza sembra soffrire di una strana amnesia selettiva. Troviamo Lise Meitner citata di sfuggita come la "Madame Curie tedesca", un’etichetta che, oltre a sminuire la sua individualità, appare chiaramente insufficiente per una scienziata che ha contribuito in modo cruciale alla scoperta della fissione nucleare. La memoria collettiva l’ha relegata nell’ombra del collega Otto Hahn, nonostante quest'ultimo abbia ricevuto il Nobel per una scoperta impossibile senza i contributi fondamentali di Meitner.
Questo non è però un caso isolato. La storia della scienza è popolata di donne la cui genialità è stata ignorata, travisata o attribuita ad altri. Certi nomi vengono riscoperti solo oggi, al termine di un laborioso processo di revisione storica. Ci si chiede come sia stato possibile dimenticare figure del calibro di Emmy Noether, la matematica tedesca che Albert Einstein definì:
"Il più grande genio creativo della matematica dai tempi in cui le donne hanno guadagnato pieno accesso alle università".
Emmy Noether fornì strumenti essenziali per la fisica moderna, gettando le basi matematiche della teoria delle simmetrie e delle leggi di conservazione, un contributo inestimabile per la comprensione della relatività generale e della meccanica quantistica. Eppure, durante la sua carriera in Germania, non le fu nemmeno permesso di insegnare ufficialmente. Teneva lezioni sotto il nome di colleghi uomini.
L’invisibilità delle donne nella scienza affonda le sue radici non solo nelle discriminazioni sociali, ma anche nell’oblio sistematico operato dalla storiografia ufficiale. L’esempio di Rosalind Franklin, la chimica e cristallografa britannica, è emblematico. Il suo lavoro sulla diffrazione a raggi X del DNA fu fondamentale per James Watson e Francis Crick nella scoperta della struttura a doppia elica. Tuttavia, quando i due ricevettero il Premio Nobel nel 1962, Rosalind Franklin era già morta. A causa delle regole dell’Accademia di Stoccolma, i premi non possono essere assegnati postumi. Ma persino in vita, il suo contributo era stato minimizzato, spesso ignorato nel dibattito accademico dell’epoca.
Un’altra storia significativa è quella di Cecilia Payne-Gaposchkin, un’astronoma britannica. Nel 1925, Payne-Gaposchkin scoprì che l’idrogeno è l’elemento principale delle stelle, una scoperta che avrebbe rivoluzionato l’astronomia. Ma il suo lavoro fu accolto con scetticismo e persino disprezzo da parte di astronomi uomini. L’astronomo Henry Norris Russell, in particolare, criticò apertamente le sue conclusioni, salvo poi appropriarsene dieci anni dopo. Payne-Gaposchkin faticò per tutta la vita a ottenere il pieno riconoscimento del suo contributo.
L'invisibilità storica delle donne nella scienza non è solo un problema di discriminazione, ma una sfida nel campo della memoria culturale. Quando si ignora o si cancella il contributo di una donna, si limita la possibilità per le generazioni future di vedere se stesse riflessi in quei traguardi. La storiografia, un tempo disciplinata da criteri esclusivamente maschili, ha creato narrazioni che estromettono le donne o le confinano a ruoli secondari. Proprio come il linguaggio plasma il pensiero, così il modo in cui raccontiamo la storia plasma il futuro. La mancanza di modelli femminili visibili non è solo un tema passato; è una questione contemporanea, radicata in squilibri ereditati ma tuttora presenti.
Non deve sorprendere quindi che molte figure femminili nella scienza abbiano trovato una sorta di riconoscimento solo decenni dopo la loro morte. Nel 2018, l'Unione Astronomica Internazionale decise di intitolare un asteroide a Lise Meitner: “6999 Meitner”. Per Rosalind Franklin, bisognerà attendere il 2021 per vedere una missione spaziale portare il suo nome. Questi riconoscimenti postumi, per quanto importanti, evidenziano il ritardo della memoria collettiva.
Un'altra figura poco celebrata è Maria Goeppert-Mayer, che nel 1963 vinse il Premio Nobel per la fisica per aver scoperto il modello a gusci del nucleo atomico. Lei stessa, però, riconobbe il contesto in cui operava. Più volte sottolineò come all’inizio della carriera nessuna università volesse assumerla, costringendola a lavorare gratuitamente come volontaria. Goeppert-Mayer dimostrò che talento e perseveranza possono sovrastare le barriere, ma allo stesso tempo confermò quanto quelle barriere fossero alte per le donne della sua epoca.
La sfida della memoria storica, dunque, non è semplicemente un atto di giustizia verso le pioniere dimenticate. È un’esigenza culturale. Recuperare la voce delle donne nella scienza significa abbattere pregiudizi e offrire una narrazione più ricca, più completa e più vera sul progresso umano. Superare questa invisibilità è un dovere non solo nei confronti del passato, ma anche verso future generazioni di scienziate.