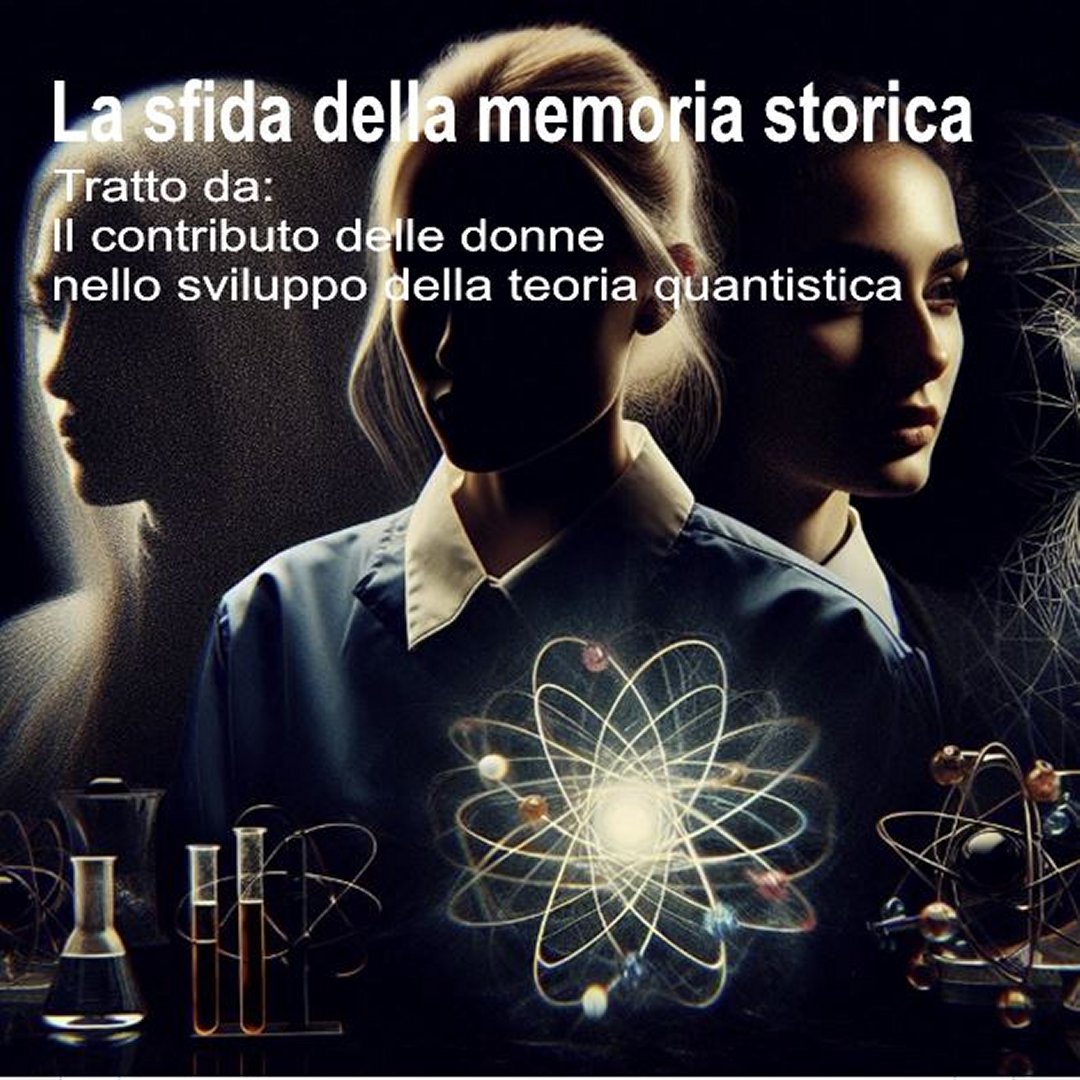Questa è una domanda antica, ma la fisica quantistica ci costringe a riformularla in modo nuovo e provocatorio. Il paradosso del Gatto di Schrödinger rappresenta il cuore di questo dilemma. In questa celebre ipotesi mentale, Erwin Schrödinger immagina un gatto chiuso in una scatola dove il suo stato, vivo o morto, dipende dal decadimento atomico, un evento governato dalle leggi della meccanica quantistica. Prima dell’osservazione, si dice, il gatto è in una “sovrapposizione di stati", sia gatto vivo che gatto morto. Ma chi determina la verità di ciò che accade nella scatola? L’osservatore diventa più di una semplice presenza. Assume un ruolo centrale, quasi ontologico, nell’esistenza stessa della realtà.
Il mondo esiste solo quando guardiamo?
La questione, che inizialmente nasce come un dibattito scientifico, assume rapidamente una dimensione filosofica e metafisica. Niels Bohr, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, sosteneva che l’atto dell’osservazione interrompe la sovrapposizione e definisce la realtà. Questo principio, noto come "collasso della funzione d’onda", implica che senza un osservatore il gatto (e, per estensione, la realtà stessa) resta sospeso in uno stato indefinito. Ma è davvero così? Il mondo, allora, esiste solo quando guardiamo?
L’idea che l’osservatore sia essenziale per la realtà ha radici che vanno oltre la fisica. George Berkeley, filosofo irlandese del XVIII secolo, sosteneva che l’esistenza degli oggetti dipende dalla percezione. La formula immortale di Berkeley è:
“Esse est percipi” (citazione latina).
(Esistere è essere percepito). Secondo Berkeley, Dio stesso è il grande osservatore che garantisce la persistenza del mondo quando nessuno lo guarda. La meccanica quantistica sembra prendere una traiettoria simile, ma senza invocare l’intervento divino. Qui, l’osservatore umano o meccanico entra come co-creatore della realtà misurata.
“Esse est percipi”: un filosofo del XVIII secolo e il sogno quantistico.
In realtà, il paradosso del Gatto di Schrödinger solleva una domanda cruciale: quanto l’osservatore influisce sulla realtà? La fisica, in questo caso la meccanica quantistica, ci dice che il solo atto di osservare modifica lo stato del sistema. Ma questo concetto ha radici che affondano ben oltre la scienza, risalendo alla filosofia e a una lunga storia di speculazione sull'importanza della percezione.
Prima della fisica quantistica, qualcuno aveva già intuito l’idea che la realtà, in fondo, dipenda dall’osservatore. George Berkeley, filosofo irlandese vissuto nel XVIII secolo, è ricordato proprio per questa provocatoria tesi. Nel suo sistema filosofico noto come “immaterialismo” (poi chiamato anche “idealismo soggettivo”), Berkeley sostiene che il mondo esiste solo se è percepito da un osservatore. La sua massima, “Esse est percipi” (“l’essere è essere percepito”), ne è la sintesi più famosa.
Ma cosa accade al mondo, secondo Berkeley, quando nessuno lo osserva? Qui entra in gioco una figura centrale: Dio. Per Berkeley, l’universo non collassa mai in un nulla indeterminato perché Dio, un osservatore eterno e onnipresente, garantisce che gli oggetti continuino a esistere anche in assenza di testimoni umani. In un certo senso, Dio svolge un ruolo simile a quello dell’osservatore nella fisica quantistica: Egli “collassa” la realtà, mantenendola stabile e coerente.
Questo collegamento tra la visione teologica di Berkeley e le implicazioni filosofiche del Gatto di Schrödinger è affascinante. Entrambi ci spingono a chiederci se la realtà sia una struttura oggettiva o una costruzione fortemente dipendente dalla coscienza di chi la osserva.
L’importanza della percezione nella cultura.
L’idea che l’osservatore crei o influenzi la realtà ha trovato spazio non solo nella filosofia e nella fisica, ma anche nell’arte, nella letteratura e nella psicologia. Pensiamo per un attimo al racconto di Jorge Luis Borges “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1940), in cui l’autore argentino immagina un mondo in cui gli oggetti non esistono se non in quanto percepiti. In quel contesto, l’osservazione non è solo un atto passivo, ma un processo creativo che genera il reale.
Anche nella pittura, ci sono opere che evocano il concetto di presenza dell’osservatore come parte dell’opera stessa. Gli specchi negli autoritratti di Jan van Eyck o Diego Velázquez (pensiamo all’iconica “Las Meninas”) ricordano che il mondo che vediamo è sempre mediato dall’occhio che guarda, e quindi soggettivo.
La stessa psicologia moderna ha affrontato il tema. Gli esperimenti di psicologia della Gestalt e alcune intuizioni della psicologia cognitiva dimostrano che non osserviamo mai la realtà in modo “puro”. La mente umana interpreta, plasma e completa ciò che vede, costruendo un’immagine coerente del mondo esterno.
Se torniamo al Gatto di Schrödinger e alla fisica quantistica, scopriamo che il ruolo dell’osservatore non è meramente accessorio. Secondo l’interpretazione classica della meccanica quantistica – detta “interpretazione di Copenaghen” e sostenuta da Niels Bohr – la funzione d’onda, che rappresenta tutte le possibili condizioni di un sistema, collassa in uno stato definitivo solo al momento dell’osservazione. Fino a quel momento, lo stato del sistema esiste in una sovrapposizione di possibilità.
Questo porta a una constatazione sconcertante: la realtà subatomica, in qualche modo, sembra “sapere” quando viene osservata. Il noto esperimento della doppia fenditura lo dimostra chiaramente. Quando gli scienziati osservano le particelle che attraversano le fenditure, queste si comportano come particelle solide. Quando invece smettono di osservare, le particelle si comportano come onde.
E se ampliamo questa visione? Se ogni osservatore fosse l'equivalente di un “Dio” berkeleiano, capace di dare solidità al reale semplicemente guardandolo? È una domanda vertiginosa, che mescola scienza, metafisica e un pizzico di poesia. L’universo, in questa luce, non è qualcosa di “dato”, ma una realtà fluida e mutevole, una tela da dipingere con la forza della nostra attenzione.
L’osservazione nella psicologia della Gestalt.
Quando Erwin Schrödinger propose il suo celebre paradosso del gatto chiuso nella scatola, non immaginava che il concetto avrebbe aperto porte non solo alla fisica quantistica e alla filosofia, ma anche alla psicologia. La questione centrale – il ruolo dell’osservatore nel determinare la realtà – non riguarda solo gli elettroni o i gatti, ma anche la nostra stessa percezione quotidiana del mondo.
La psicologia della Gestalt è una corrente psicologica che studia come la mente umana percepisce e organizza le informazioni, enfatizzando il fatto che il tutto è diverso dalla somma delle sue parti. Essa sostiene che le persone interpretano la realtà attraverso schemi innati e processi attivi, costruendo significati completi a partire da stimoli parziali.
Nei primi anni del XX secolo, i ricercatori della psicologia della Gestalt, come Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka, iniziarono a esaminare il modo in cui la mente umana percepisce il mondo esterno. Una delle loro scoperte fondamentali fu che non possiamo mai osservare la realtà in modo “puro”. La mente interviene sempre, riorganizzando, completando e interpretando ciò che percepiamo per costruire un’immagine coerente.
Un esempio famoso è il cosiddetto “Triangolo di Kanizsa” (inventato dallo psicologo Gaetano Kanizsa nel 1955). Quando guardiamo il disegno – composto solo di segmenti e figure incomplete – il cervello vede chiaramente un triangolo bianco che, in realtà, non esiste. La nostra mente crea qualcosa dal nulla per dare un senso coerente a ciò che appare ai nostri occhi. È un triangolo che non è mai stato messo volontariamente nella composizione della figura, proprio come il gatto nella scatola non è vivo né morto fino a che non lo osserviamo.
La lezione della psicologia della Gestalt è chiara: non siamo mai semplici spettatori della realtà. Ne siamo co-creatori.
La lezione della psicologia della Gestalt è chiara: non siamo mai semplici spettatori della realtà. Ne siamo co-creatori.
La psicologia cognitiva.
La psicologia cognitiva, sviluppatasi a metà del XX secolo, ha aggiunto ulteriori dettagli a questa visione. Secondo studiosi come Ulric Neisser, padre della psicologia cognitiva moderna, la percezione non è mai un processo passivo. Il cervello non si limita a ricevere informazioni. Esso rielabora, seleziona e completa ciò che manca, proprio come un regista che monta un film.
Un aneddoto illuminante, in questo senso, proviene dai lavori di Frederic Bartlett, famoso psicologo britannico nel campo della memoria. Bartlett condusse negli anni Trenta un esperimento in cui le persone leggevano una storia appartenente a una cultura molto diversa dalla loro, quella dei nativi americani. Quando veniva chiesto di ricordarla, i soggetti ricostruivano inconsapevolmente i dettagli, sostituendo gli elementi che non capivano con quelli della loro tradizione culturale. Ad esempio, un particolare rituale descritto nel racconto diventava improvvisamente una “messa” per lettori occidentali.
Questo ci porta a un punto essenziale. L’esperienza personale, la cultura e l’immaginazione influenzano ciò che vediamo, ciò che ricordiamo e, in un certo senso, ciò che “è reale” per noi. Come diceva Einstein:
“La realtà è solo un’illusione, sebbene molto persistente”.
Tutto ciò ci riconduce al Gatto di Schrödinger e al paradosso della fisica quantistica. La percezione, sia a livello quantistico che umano, non è mai un semplice “guardare dentro la scatola”. L’atto di osservare implica sempre una rielaborazione da parte della mente. Non vediamo mai “il gatto”, vediamo la nostra interpretazione del gatto.
In tutto ciò, la psicologia offre un avvertimento: non fidarti ciecamente di ciò che osservi. La mente umana non è una telecamera, ma una lente creativa. Come in un’opera teatrale, noi partecipiamo attivamente alla costruzione del mondo che percepiamo. E nel fare ciò, partecipiamo – proprio come nella meccanica quantistica – alla creazione stessa della realtà.
Tendere un filo tra la fisica quantistica, la filosofia e la psicologia non è solo un gioco intellettuale. È un invito a guardare il mondo con occhi più consapevoli. Lo stesso Paradosso del Gatto e i contributi della psicologia moderna ci ricordano che l’osservatore, che sia uno scienziato, un filosofo o una persona qualunque, non è mai inerte. Osservare significa creare.
Un enigma ancora aperto.
Oggi, il gatto di Schrödinger vive nell’immaginazione collettiva come simbolo di paradossi e misteri. Eppure, dietro la sua storia si cela la più antica delle domande: cosa è reale? La fisica quantistica suggerisce che la risposta potrebbe risiedere nella coscienza dello spettatore, un’idea che continua a far discutere scienziati, filosofi e artisti. In fondo, ogni volta che alziamo gli occhi per osservare il cielo notturno, siamo anche noi, almeno un po’, creatori del cosmo che vediamo.
Come scrisse Marcel Proust nel suo libro “Alla ricerca del tempo perduto”:
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”.
E forse quei nuovi occhi, come nel caso del gatto di Schrödinger, non osservano soltanto l’universo, ma lo rendono possibile.
Albert Einstein rigettò con forza questa idea. La sua celebre teoria:
"La luna è lì anche se non la guardo",
riassume il suo scetticismo verso una realtà dipendente dall’osservazione. Ma prove sperimentali, come l’esperimento della doppia fenditura, sollevano dubbi. In questo test cruciale, la luce si comporta a volte come onda, a volte come particella, a seconda che qualcuno osservi il fenomeno. Il risultato sembra trasmettere un messaggio surreale: il comportamento della materia è influenzato dall’atto del guardare.