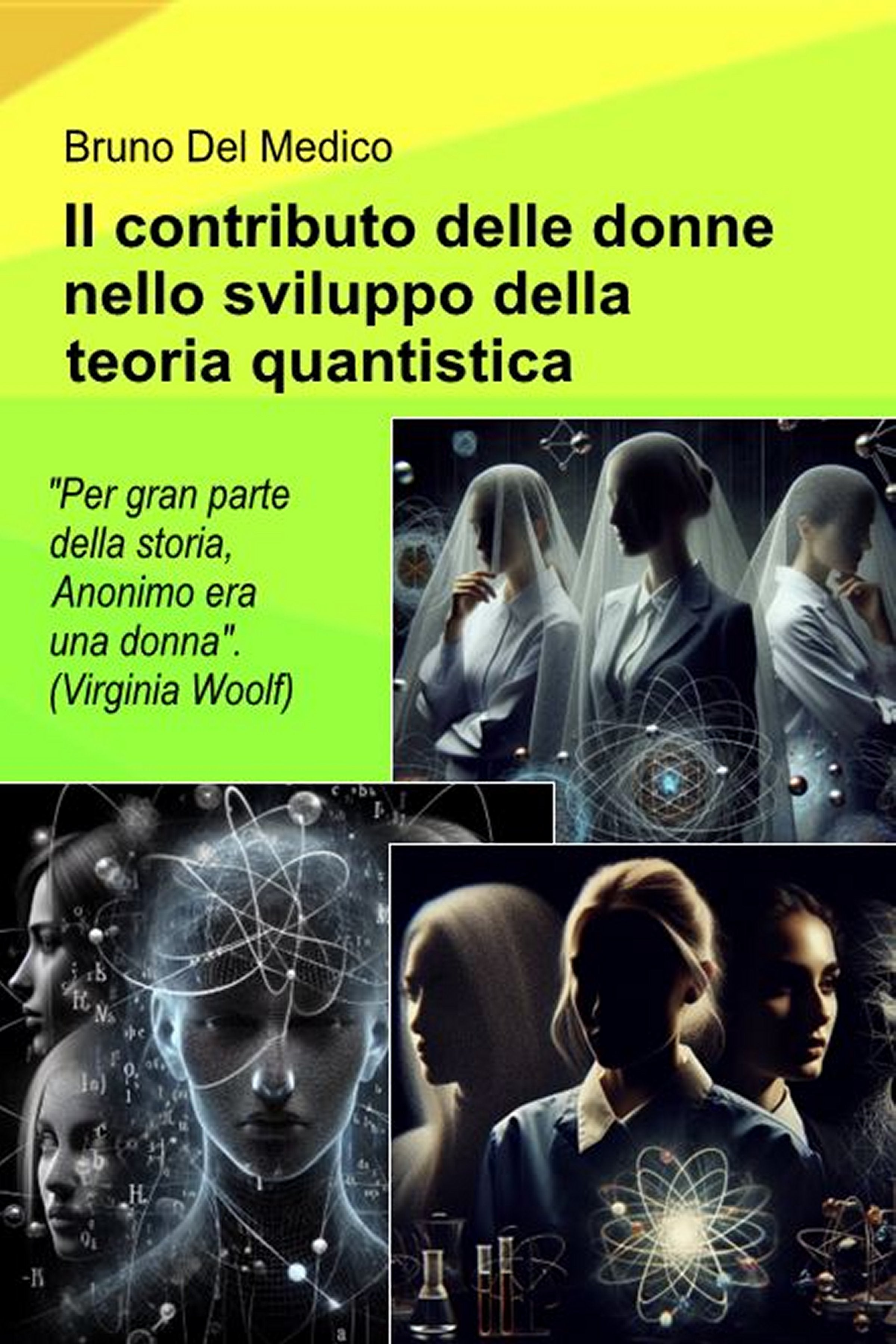
Giardino Quantico
Il contributo delle donne nello sviluppo della teoria quantistica
Scegli le opzioni
Autore: Bruno Del Medico
Pagine: 324 Formato cm. 17x24
Collana: Cenacolo Jung Pauli
Peso 500 grammi. (0,5 kg.). Peso massimo consentito per la spedizione nei paesi europei: 2 kg. Per l'Italia, 5 kg.
Anno di pubblicazione e ISBN: 2050, 9788832273397
Puoi trovare questo libro anche in FORMATO DIGITALE (Ebook in PDF, Epub, Mobi).
Puoi trovare questo libro anche in RILEGATURA CARTONATA (adatto a un regalo di classe). Vedi il SOMMARIO COMPLETO dei contenuti di questo libro.
LEGGI un brano di questo libro nel blog.
Questo libro può essere spedito in Italia e nella Comunità Europea. Vedi i TEMPI E COSTI DI SPEDIZIONE e le MODALITA' DI ACQUISTO . Vedi anche. Pagamento con carta di credito. La versione digitale (ebook) può essere consegnata ovunque senza spese.
Sinossi
"Durante gran parte della storia, Anonimo era una donna". (Virginia Woolf)
La scienza, per molti secoli, è stata un regno dominato dagli uomini. Non per mancanza di talento o intuizione da parte delle donne, ma per le strutture sociali e culturali che le hanno sistematicamente escluse. Questo fenomeno è particolarmente evidente nella storia della fisica, e ancor di più nello sviluppo della teoria quantistica. Cosa ne sarebbe stato della scienza moderna se i nomi di queste donne fossero stati riconosciuti al pari di quelli dei loro colleghi uomini? Questa è una domanda che il nostro tempo non può più ignorare.
Un esempio emblematico di questa invisibilità storica è la vicenda di Lise Meitner, una fisica straordinaria che ha contribuito alla scoperta della fissione nucleare. Era il 1938 quando Otto Hahn, suo collega di lunga data, ricevette il merito esclusivo per questa scoperta, guadagnandosi successivamente un Premio Nobel. Lise Meitner, invece, fu relegata ai margini della storia scientifica, nonostante i suoi calcoli fondamentali che permisero di comprendere il processo di fissione. “Una mente che non ha mai perso la chiarezza”, così la descriveva Albert Einstein, ma ciò non bastò a garantirle il riconoscimento. Lise Meitner, che era ebrea e dovette fuggire dalla Germania nazista, ha portato avanti il suo lavoro in un contesto che era ostile sia al suo sesso che alla sua identità.
La storia di queste donne non è solo scientifica, ma profondamente culturale. Perfino nel mondo della letteratura, il tema dell'invisibilità femminile nelle professioni intellettuali è stato sollevato con forza. Virginia Woolf, nel suo celebre saggio “Una stanza tutta per sé” (1929), rifletteva su cosa avrebbe potuto fare una giovane donna del genio di Shakespeare se fosse vissuta ai suoi tempi. Woolf immaginava che questa figura, “Judith Shakespeare”, non avrebbe mai avuto l’opportunità di emergere. La stessa immagine si applica perfettamente alla scienza: quante donne hanno avuto il genio e la lucidità di una Marie Curie, ma non hanno mai avuto accesso alle risorse, ai laboratori, o alle reti di collaborazione necessarie per esprimersi?
Il caso della teoria quantistica è particolarmente interessante. Questa branca della fisica, che ha trasformato la nostra comprensione del mondo subatomico, si è sviluppata grazie a una comunità di menti brillanti, molte delle quali donne. Tuttavia, solo pochi nomi sono rimasti impressi nella narrazione storica. Uno di questi è quello di Maria Goeppert Mayer, la seconda donna nella storia a vincere un Premio Nobel per la fisica (1963), per il suo modello del nucleo atomico. Per anni, Maria lavorò in condizioni precarie, spesso senza ricevere uno stipendio adeguato, limitata dal pregiudizio nei confronti delle donne “mogli di scienziati”. Ciononostante, il suo contributo fu fondamentale per la fisica moderna.
Oltre agli esempi individuali, esiste una riflessione più ampia sul “perché” di questa invisibilità. Storicamente, le ricerche delle donne venivano pubblicate con i nomi dei loro mariti o colleghi uomini, rendendo complicato identificarne il reale contributo. In molti casi, alle donne era persino proibito accedere alle università o ai laboratori. Un esempio simbolico è quello della Royal Society di Londra, una delle istituzioni scientifiche più prestigiose al mondo, che accettò la prima donna come membro solo nel 1945, quasi tre secoli dopo la sua fondazione.
Non sorprende, quindi, che molte di queste donne abbiano trovato spazio marginale anche nella memoria popolare e accademica. Perfino oggi, le loro storie rimangono spesso sconosciute. Eppure, il loro lavoro continua a influenzare profondamente il nostro modo di vedere il mondo. La fisica quantistica non sarebbe ciò che è senza le menti di queste donne.
Scrivere di donne e scienza, e in particolare delle loro conquiste nel mondo della teoria quantistica, non è solo un atto di giustizia storica. È anche una riflessione sul presente e sul futuro. L’obiettivo di tutti non è recuperare semplicemente i nomi e le storie perdute, ma ispirare nuove generazioni di ragazze e ragazzi a immaginare un mondo in cui il genio non abbia genere. La visione di Woolf e la dedizione di donne come Meitner e Goeppert Mayer devono essere il faro di chi oggi si avvicina alla scienza, ricordandoci che la conoscenza si sviluppa davvero solo quando tutti hanno la possibilità di contribuire.
Il libro non si limita a raccontare grandi scoperte, ma si propone di avviare una riflessione su come una partecipazione più inclusiva nella scienza possa portare a nuove possibilità di comprensione del mondo. Gli esempi personali delle protagoniste, intrecciati con il contesto sociale e filosofico, creano una narrativa potente e stimolante per il lettore.
