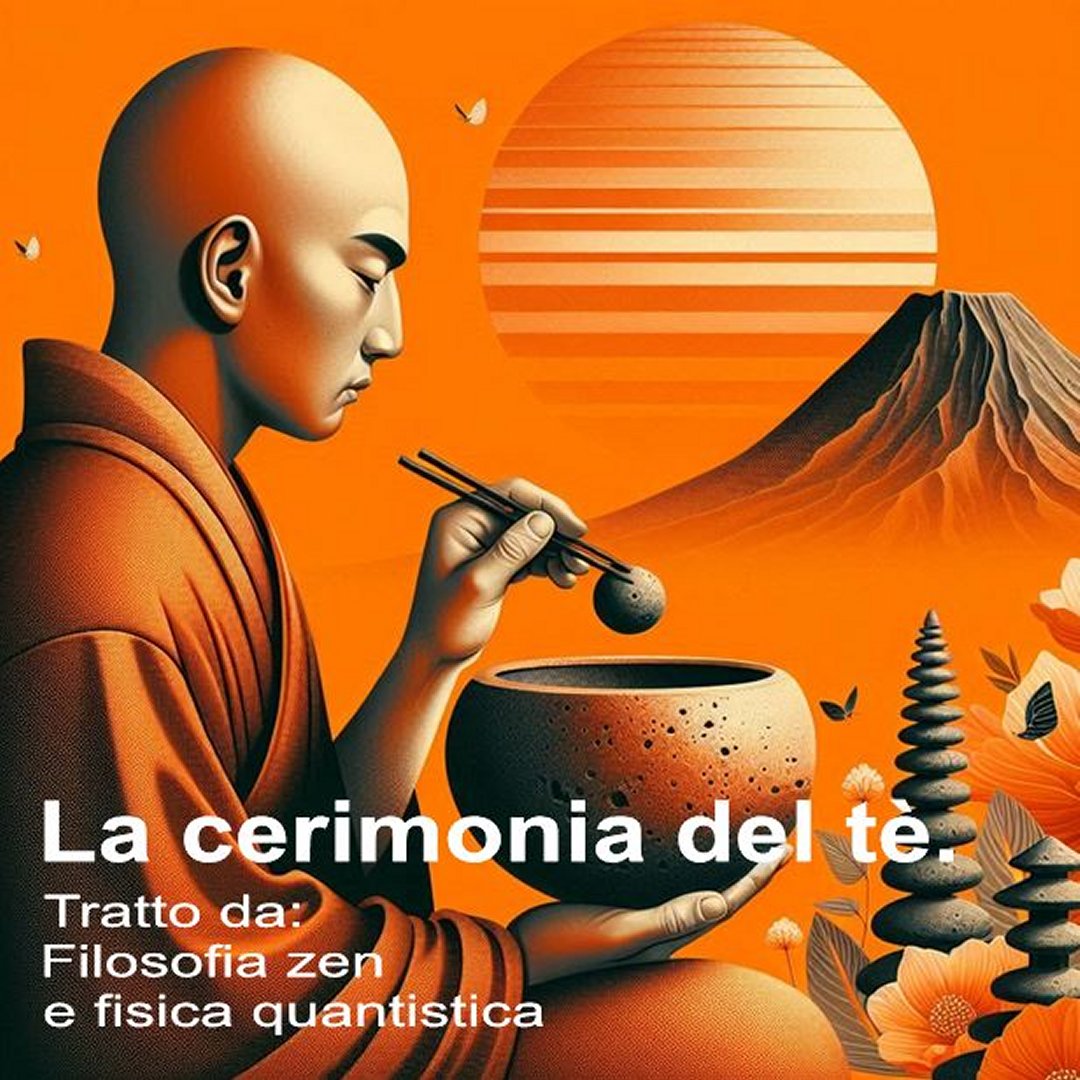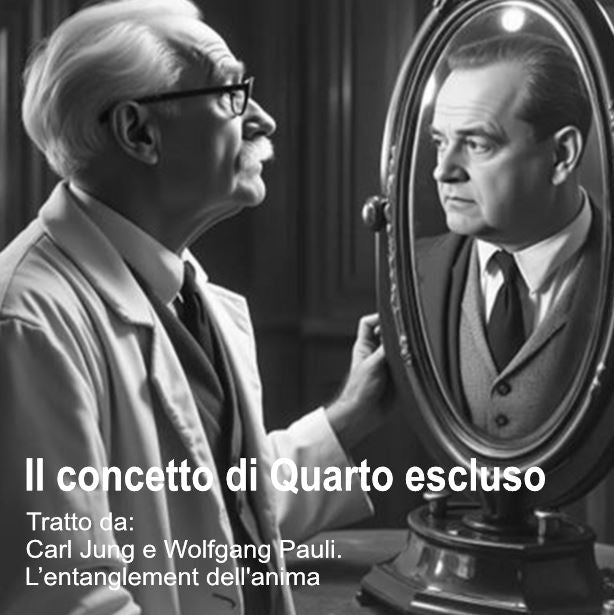La cerimonia del tè.
(Tratto da: Filosofia zen e fisica quantistica)
Nel Giappone antico, l’arte della cerimonia del tè, codificata da Sen no Rikyū nel XVI secolo, rappresenta una delle espressioni più pure di questa filosofia. Sen no Rikyū, maestro di cerimonia e poeta, ridusse ogni eccesso, preferendo utensili sobri e ambienti austeri. Per lui, la vera bellezza era nascosta nella semplicità di un gesto ben fatto, nell’armonia fra le mani dell’uomo e la materia quotidiana. Rikyū, diceva:
“Il vero spirito del tè è spazzare il giardino, disporre i fiori, scaldare l’acqua e versare il tè senza preoccuparsi che nulla possa essere superfluo.”
In un piccolo padiglione con porte scorrevoli di carta e legno, il fluire del tempo rallenta. Qui, la cerimonia del tè (cha no yu) accoglie gli ospiti in Giappone dalla fine del XV secolo. Un semplice gesto, come versare acqua calda su polvere di tè verde, diventa un rito ricco di silenzio e di intenzione. Non è solo estetica, ma profondo esercizio spirituale: la cerimonia del tè è una delle espressioni più pure della filosofia zen.
Il monaco Sen no Rikyū, vissuto nel XVI secolo, ne codificò i principi fondamentali: armonia (wa), rispetto (kei), purezza (sei), tranquillità (jaku). Rikyū, nel caos delle guerre feudali, trovava nell'estrema essenzialità un argine all'inquietudine.
Ma cosa ha a che fare tutto ciò con la fisica quantistica? Apparentemente nulla. In realtà, il legame tra lo Zen filtrato dalla cerimonia del tè e la fisica quantistica risiede in una sorprendente convergenza di prospettive. Il fisico danese Niels Bohr, insignito del Nobel nel 1922, esponeva la “complementarità”: nella meccanica quantistica, la realtà non è una, ma molteplice e dipendente dalla relazione tra osservatore e osservato. Bohr stesso, nel progettare lo stemma del suo casato, scelse il simbolo orientale dello yin e yang.
La cerimonia del tè ci invita ad abbracciare la molteplicità sottile del presente. L’ospite si fa spettatore e attore, il maestro compie gesti tanto perfetti quanto effimeri. Qui “la foglia che cade” diventa universo, come diceva il poeta Matsuo Bashō. Ogni dettaglio – il bricco, la tazza raku, il suono dell’acqua – non ha significato assoluto, ma acquista valore dal rapporto con gli altri e dal pensiero dell’attimo.
Questo è un insegnamento centrale anche nella fisica quantistica. Il famoso “esperimento della doppia fenditura” mostra che la luce può essere sia onda che particella: la realtà si trasforma a seconda di come viene osservata. Allo stesso modo, nella cerimonia del tè, la piena consapevolezza dell’istante, la sospensione delle altre possibilità, rende unica ogni esperienza.
Il tempio di Uji, vicino Kyoto, con i suoi secolari campi di tè, è oggi meta di pellegrinaggio per appassionati e ricercatori. Si narra che il maestro zen Sen Sōtan, nipote di Rikyū, si confrontò con un visitatore occidentale spiegando:
“La cerimonia del tè insegna a vedere il mondo in una sola tazza.”
Il fisico Werner Heisenberg, padre del principio di indeterminazione, avrebbe potuto aggiungere:
“E ogni tazza contiene infinite possibilità.”
Oggi, neuroscienziati e filosofi rileggono i classici dello zen, come il “Libro del tè” di Okakura Kakuzō, non solo come manuali di estetica, ma come ponti tra culture e paradigmi. La cerimonia del tè non pretende risposte definitive: offre invece spazi di contemplazione, così come la fisica quantistica ci offre domande. Il marciapiede erboso che conduce al padiglione è lo stesso sentiero dell’incertezza e della meraviglia.
Quando l’ultimo sorso di tè verde scalda le mani dell’ospite, rimane la sensazione di aver partecipato a qualcosa di unico e inatteso. Forse, davanti a una tazza fumante e silenziosa, troviamo quel punto dove la filosofia zen e la fisica quantistica finalmente si toccano: nell’infinita preziosità dell’adesso.